La Coturnice – Quaderni della Biodiversità
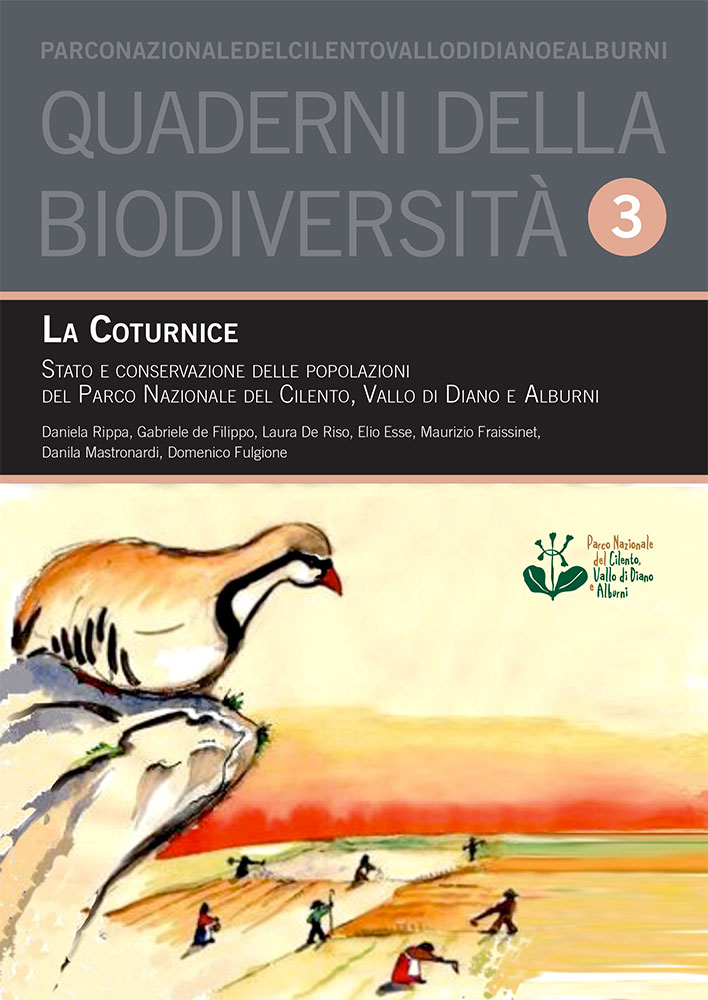
“La Coturnice” – Quaderni della Biodiversità n. 3. Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Daniela Rippa, Gabriele de Filippo, Laura De Riso, Elio Esse, Maurizio Fraissinet, Danila Mastronardi, Domenico Fulgione. Per averne una copia effettuare un bonifico di 5 euro per le spese postali sul conto corrente bancario dell’ASOIM presso la filiale di Banca Etica. L’IBAN è IT81 P050 1803 4000 0000 0164 911 e il conto corrente è intestato a Associazione Studi Ornitologici. Effettuato il versamento inviare una email a info@asoim.org per comunicare la data del bonifico e l’indirizzo a cui si vuole ricevere il libro, specificando anche il nome e cognome. Il libro viaggia come pieghe di libri.
Sterpazzola della Sardegna – Avifauna della Campania – Monografia n. 12
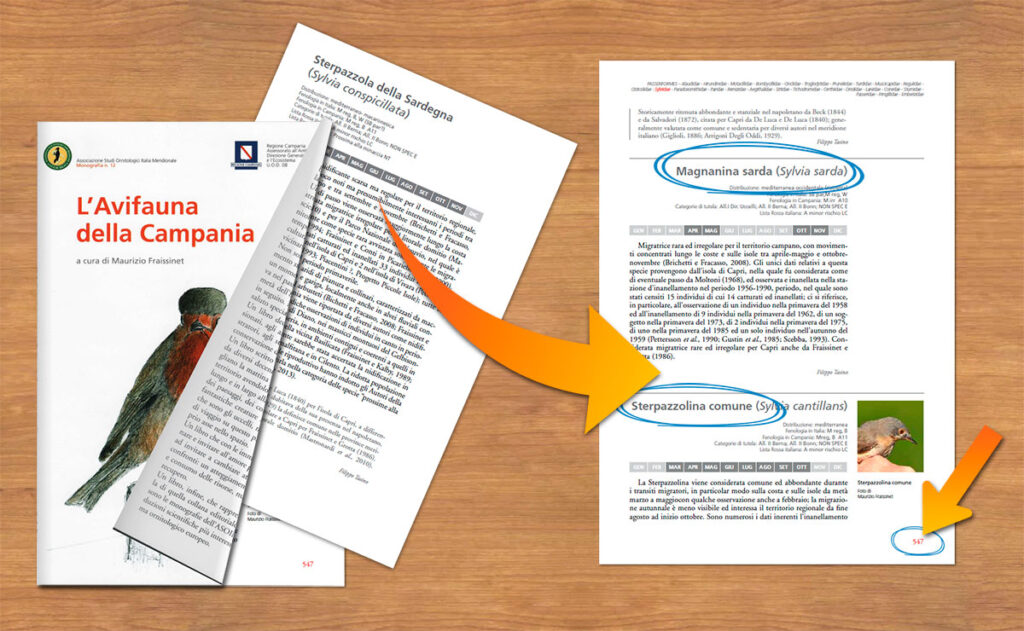
“Un errore nell’impaginazione del libro L’Avifauna della Campania – Monografia ASOIM n. 12, ha lasciato fuori il testo sulla Sterpazzola della Sardegna. Lo riportiamo qui di seguito e chiunque può scaricarlo. All’interno del libro la pagina sulla Sterpazzola della Sardegna va inserito a pag. 547, con maggiore precisione l’integrazione è da intendersi dopo il testo sulla Magnanina sarda e prima di quello sulla Sterpazzolina comune. Ci scusiamo per l’errore“
Checklist Uccelli della Campania – 31 gennaio 2016
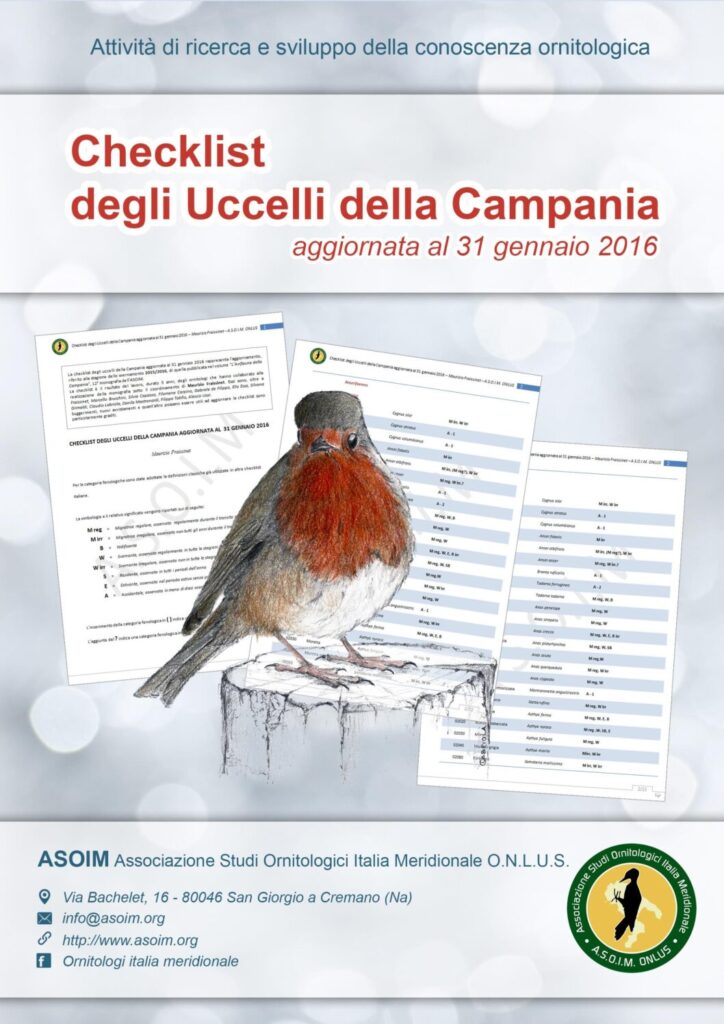
La checklist degli uccelli della Campania aggiornata al 31 gennaio 2016 rappresenta l’aggiornamento, riferito alla stagione dello svernamento 2015/2016, di quella pubblicata nel volume “L’Avifauna della Campania”, 12° monografia dell’ASOIM. Sono riportate 359 specie, ripartite in 20 ordini e 77 famiglie. 152 sono le specie che risultano nidificanti sul territorio regionale, 53 vi sostano per periodi più o meno lunghi in inverno insieme alle specie residenti, 132 sono da considerare specie migratrici regolari e irregolari, 66 le accidentali La checklist è il risultato del lavoro, durato 3 anni, degli ornitologi che hanno collaborato alla realizzazione della monografia sotto il coordinamento di Maurizio Fraissinet. Essi sono, oltre a Fraissinet, Marcello Bruschini, Silvia Capasso, Filomena Carpino, Gabriele de Filippo, Elio Esse, Silvana Grimaldi, Claudio Labriola, Danila Mastronardi, Filippo Tatino, Alessio Usai. Suggerimenti, nuovi avvistamenti e quant’altro possa essere utile ad aggiornare la check-list è particolarmente gradito.
Contatti sonori QR code.

Contatti sonori i richiami dei passeriformi. Articolo di Paolo Marotto da I “Quaderni di Birdwatching” di EBN Italia. Cit.: “Con questo articolo cercherò di analizzare un aspetto che spesso causa profonde frustrazioni in chi si avvicina a questa difficile arte: l’impossibilità, in molti casi, di arrivare a una sicura identificazione della specie in presenza di poche note. L’entusiasmo e il desiderio di “dare un nome” a tutti gli uccelli incontrati possono essere fattori fuorvianti per una determinazione obiettiva …” (continua) Come fare a sentire l’audio con QR-code I codici QR sono icone che permettono al vostro smartphone di ottenere informazioni codificate, come ad esempio in questo caso, un collegamento internet. Per ottenere il lettore QR scaricate gratuitamente l’app su Android, oppure per IOS si ITunes. Aprite l’app e inquadrate l’icona QR presente accanto allo spettrogramma: fatto! Sentire l’audio! Ovviamente dovete avere un collegamento internet 3G o wifi.
Check-list degli uccelli italiana aggiornata al 2014 – P.Brichetti e G.Fracasso

Allego la recente check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. check-list italia 2014
DISTRIBUZIONE ED ECOLOGIA RIPRODUTTIVA DELLA GHIANDAIA MARINA CORACIAS GARRULUS NELLA PROVINCIA DI CASERTA: PRIMO ANNO DI STUDIO

Danila Mastronardi* , Silvia Capasso*,Maurizio de Vita*, Anna Digilio*, Giuseppe Di Martino*,Elio Esse*, Maurizio Fraissinet*, Stefano Giustino*, Silvana Grimaldi*, Stefano Piciocchi*, Filippo Tatino*, Alessio Usai**. *Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale – A.S.O.I.M. – onlus – Via Luca Giordano 12, 80046. S.Giorgio a Cremano (NA) **Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Volturno-Costa di Licola” e “Lago di Falciano” www.asoim.org – e-mail: danila.mastronardi@tin.it Distribution and reproductive ecology of Coracias garrulus in the province of Caserta: first year of study. Abstract The Roller breeds in the province of Caserta, in the alluvial plain between Volturno and Garigliano rivers. The area is characterized by farmlands cultivated with alternating fodder, corn, and woody cultivations in low percentage. The activity began in 2012 but it was only in 2014 that its methodology was standardized. Roller breeds in cavities, in ruins partially utilized for agricultural purposes or abandoned ones. In 2014 96 ruins were monitored, of which 13 inhabited by the Roller with a percentage of 12%. The authors have noted a preference towards ruins with a roof; relations between vehicular traffic, distance from the road are not significant. The farmlands in which Roller are present are 80% herbaceous plants, 7% woody plants, 5,8 hedges and rows, 4,5 % channels, 3,2 % greenhouses and fotovoltaic panel. During these years of study, .we never documented more than two fledgings per pair. INTRODUZIONE La Ghiandaia marina Coracias garrulus è specie politipica a distribuzione euroturanico-mediterranea, con una popolazione europea di 53.000 – 110.000 coppie (Brichetti e Fracasso, 2007). Per quanto riguarda la Regione Campania, la specie non è riportata nell’Atlante degli uccelli nidificanti (Fraissinet e Kalby, 1989), però citata come nidificante da Grimmett e Jones (1989) nelle gole del fiume Calore (SA). Scebba (1993) riferisce di alcuni individui sotto i viadotti autostradali nel tratto Padula-Lagonegro (Landolfo) e riporta la nidificazione della specie negli anni ’60 lungo il corso del Volturno presso Grazzanise. Mancuso et al.(2008) in un lavoro sull’avifauna dell’Oasi WWF di Persano (SA) considerano la specie migratrice irregolare, nidificante fino alla metà degli anni ’70 nei fori del ponte ferroviario che attraversa il fiume Tenza; gli autori riportano osservazioni sui fili elettrici della SS 19 fino all’inizio degli anni ’80 (Indelli, 1992). La specie è SPEC 2, è inserita nell’All. I della Dir. Uccelli, è considerata “in pericolo” nella lista Rossa nazionale (LIPU e WWF,1999). Nella recente Lista Rossa regionale è classificata come specie minacciata di estinzione (Fraissinet e Russo, 2013). L’area agricola posta a est della via Domiziana, ricadente in gran parte nei comuni di Pescopagano e Cancello Arnone, era nota per ospitare alcune coppie di Coracias garrulus (Landolfo F., dati inediti). Anche in un antico lavoro (Cannaviello, 1898) si parla di tre coppie nidificanti a Cacello, intendendo con ogni probabilità il comune di Cancello Arnone. Il grande interesse rivestito dalla specie e l’esigenza di approfondire la conoscenza della popolazione casertana hanno indotto i soci dell’Asoim ad aderire, nel 2011, al progetto nazionale “Coracias”. In questo lavoro si riportano i risultati dei primi anni di indagine tesi a valutare l’ampiezza dell’areale riproduttivo nell’area di studio, la consistenza della popolazione, le preferenze riguardo i siti di nidificazione. Vengono fornite prime indicazioni sull’uso del suolo intorno ai siti e brevi note di biologia riproduttiva. Area di studio L’area è situata in piena Campania felix a est della Via Domitiana situata nella piana fra i fiumi Volturno e Garigliano. Si sviluppa interamente in pianura al livello del mare ed è caratterizzata da un ambiente a seminativi ripartito principalmente tra le foraggere avvicendate, le ortive e i cereali; è percorsa da fasce alberate, siepi e canali sia di bonifica (Regi Lagni) che di irrigazione. Minore estensione è destinata alle coltivazioni legnose, in massima parte fruttiferi. Numerosi i filari alberati soprattutto a Eucalipto (Eucalyptus sp.) o arbustivi spesso a Rovo (Rubus ulmifolius). Materiale Dist.strada (m) Vol.traff . Uso antropico Tetto Tufo Altro 0-20 21- 100 >100 A M B SI NO Parz SI NO Parz 95 1 42 41 13 18 37 41 1 89 6 39 45 12 Tabella 1: Caratteristiche dei 96 ruderi monitorati. Materiale Dist.strada (m) Vol. traff. Uso antropico Tetto Tufo Altro 0-20 21- 100 >100 A M B SI NO Parz SI NO Parz 12 0 5 5 2 2 4 6 0 10 2 10 2 0 Tabella 2: Caratteristiche dei ruderi presso cui è stata osservata la specie. Figura 1: Proporzione di ruderi con tetto nei due sottoinsiemi “Presenza” e “Assenza” della specie. Range min-max Valore medio Coltivazioni erbacee 60 ÷ 90 % 80% Coltivazioni legnose 0 ÷ 35% 7,08% Siepi e filari 0 ÷10% 5,8% Canali 0 ÷ 5% 4,5% Serre 0÷20 % 1,66% Impianti fotovoltaici 0÷20% 1,66% Tabella 3: uso del suolo dei siti occupati dalla Ghiandaia marina. Metodi Nei primi due anni l’indagine è stata effettuata senza l’utilizzo di una metodologia standardizzata, con l’unico scopo di contribuire alla raccolta dati per il progetto nazionale. In questa prima fase erano state individuate alcune coppie nidificanti in un’area agricola piuttosto limitata caratterizzata dalla presenza di numerosi ruderi abbandonati, manufatto scelto dalla specie per la riproduzione nell’area di studio. In questa fase l’area monitorata è stata approssimativamente di 64 km2. Nella stagione riproduttiva 2014 il lavoro è proseguito con la seguente metodologia: è stata individuata un’area di circa 375 km2 fra i comuni di Mondragone e Carinola a nord, Ischitella e Carditello a sud, comprendente quella di presenza accertata,caratterizzata da tipologie ambientali idonee all’insediamento della specie. L’area è stata divisa in sei quadranti ognuno dei quali è stato affidato ad una squadra di ornitologi. In ciascuno di essi sono stati monitorati, almeno due volte durante la stagione riproduttiva, tutti i ruderi presenti. Nel mese di luglio si sono intensificate le visite ai siti attivi. Ogni rudere controllato veniva georeferenziato e descritto secondo i seguenti parametri: altezza del manufatto, presenza del tetto, vicinanza alla strada, intensità del traffico veicolare (dove A=N.auto/min>1 M= N.auto/min=1; B=N.auto/min≤0,2), uso da parte dell’uomo. I siti dove la specie
Francesco Velatta, Giuseppina Lombardi, Umberto Sergiacomi e Paolo Viali, 2010 – Monitoraggio dell’avifauna umbra (2000 – 2005). Trend e distribuzione ambientale delle specie comuni. I Quaderni dell’Osservatorio Faunistico Regionale, Numero speciale.
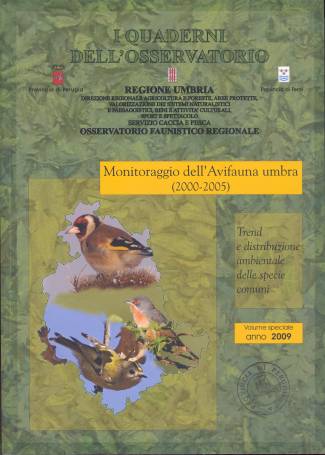
A partire dal 2000 l’Osservatorio Faunistico Regionale dell’Umbria, insieme alle Province di Perugia e Terni, organizza e coordina campagne di rilevamento ornitologico finalizzate allo studio delle popolazioni di Uccelli nidificanti e svernanti in Umbria, con particolare riferimento alle specie comuni. Gli obiettivi del programma regionale sono quelli di ottenere indici di tendenza demografica, descrivere le comunità ornitiche dei diversi tipi di ambienti, descrivere l’habitat caratteristico delle varie specie. Obiettivi ambiziosi che richiedono un impegno e una professionalità non da poco per raggiungerli. Ebbene questo grande volume di circa 390 pagine rappresenta la dimostrazione che gli ornitologi umbri sono riusciti nell’intento. Il libro infatti presenta i risultati delle indagini di monitoraggio condotte dalla stagione riproduttiva di maggio – giugno 2000 a quella di maggio – giugno 2005 e dalla stagione invernale di dicembre 2000 – gennaio 2001 a quella di dicembre 2005 – gennaio 2006. Le indagini si sono basate sulla copertura fornita da 1690 stazioni di rilevamento distribuite sull’intero territorio regionale e ripetute in ogni inverno ed in ogni stagione riproduttiva. Dopo una parte iniziale in cui vengono illustrati in maniera chiara i metodi utilizzati, le diverse realtà ecosistemiche presenti sul territorio umbro, presentate peraltro anche con un ottimo corredo fotografico, e l’analisi dei risultati generali, si passa ad analizzare i risultati relativi alle 72 specie più comuni, riportando per ciascuna di esse una scheda monografica contenente la distribuzione regionale delle stazioni in cui la specie è stata rinvenuta in almeno una sessione di rilevamento, la frequenza di rinvenimento nel campione di rilievi puntiformi e l’indice di ampiezza d’habitat di Pielou relativo alla distribuzione ambientale, l’indice puntiforme di abbondanza nelle 12 categorie ambientali prese in considerazione, i risultati del test di Kruskal – Wallis per il confronto simultaneo delle abbondanze fra categorie ambientali, l’indice di preferenza di Jacobs relativo alle diverse categorie ambientali, il baricentro relativo ad ognuna delle diverse tipologie di uso del suolo, i risultati dell’analisi di regressione multipla stepwise, l’indice puntiforme di abbondanza per fascia altitudinale, i risultati dell’indice di Kruskal – Wallis per il confronto simultaneo delle abbondanze fra fasce altitudinali, la quota minima e massima di rinvenimento e baricentro altitudinale, i risultati dell’analisi del trend effettuato mediante TRIM e l’andamento osservato dell’indice di popolazione e corrispondente tendenza calcolata da TRIM. Il tutto realizzato con una chiarezza e pulizia grafica eccellenti. Che dire. C’è da restare senza parole dinanzi ad un’opera di così vasta portata che ci inorgoglisce come ornitologi italiani, ma che, nel contempo non può suscitare un po’ di invidia nei confronti dei colleghi umbri. Invidia che si trasforma subito in complimenti vivissimi. Il volume può essere richiesto all’Osservatorio Faunistico dell’Umbria presso la Direzione regionale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo, servizio caccia e pesca. Un’opera utilissima per chi effettua studi di monitoraggio delle specie comuni e per chi voglia approfondire le tecniche di monitoraggio e di analisi dei dati. Maurizio Fraissinet
il monitoraggio contemporaneo degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide casertane e lago patria nel 2015
in questi giorni abbiamo completato la raccolta dei dati relativi al monitoraggio contemporaneo che abbiamo condotto il 18 gennaio nelle zone umide del casertano e al Lago Patria. Gli amici sanniti si sono anch’essi recati all’Oasi WWF di Campolattaro per fare osservazioni in contemporanea con noi, ma il maltempo è stato tale da impedire loro letteralmente di uscire dal centro visite, anche perché le nuvole erano talmente basse da impedire qualsiasi tipo di osservazioni. In primo luogo i numeri per avere un’idea di quanto abbiamo realizzato tutti insieme: siamo stati in 24 rilevatori divisi in 5 squadre e abbiamo visitato 15 località, abbiamo osservato 13840 uccelli di 46 specie diverse. Dal confronto dei totali di quest’anno con quelli dello scorso anno si possono notare ad un primo esame alcune risultanze interessanti. Sono stati osservati più uccelli rispetto all’anno precedente, nonostante quest’anno la giornata sia stata funestata da condizioni meteorologiche quasi proibitive e da alcuni contrattempi che hanno impedito di vistare una località (la foce del Garigliano) e hanno ridotto le possibilità di visita in un’altra: il lago di Falciano. Entrando nel dettaglio delle specie,ci sono state alcune interessanti osservazioni di specie accidentali o comunque rare: Cigno minore, Moretta grigia, Orco marino, Gabbiano corso. Si notano scarti in negativo di una certa consistenza per Volpoca, Canapiglia, Alzavola, Svasso maggiore, Airone bianco maggiore, Airone guardabuoi, Pavoncella, Beccaccino, Piovanello tridattilo e Piovanello pancianera. Per lo Svasso maggiore va detto che il fenomeno sembra avere dimensione regionale, per i dati che stiamo raccogliendo dalle zone umide e costiere delle altre province campane. Per l’Airone guardabuoi è molto probabile, invece, che una buona parte della popolazione sia sfuggita al conteggio perché intenta a pascolare su terreni in località non prese in considerazione per la contemporanea. Il calo dell’Airone bianco maggiore, al momento, non sembrerebbe trovare riscontri nelle zone umide delle altre province campane. Si notano scarti in positivo di una certa consistenza invece per Germano reale, Codone, Moriglione, Moretta, Moretta tabaccata, Tuffetto, Svasso piccolo, Sula, Cormorano, Gallinella d’acqua, Folaga (1000 in più rispetto allo scorso anno), Pettegola, Gabbiano reale, Gabbiano comune e Martin pescatore (per questa specie si conferma il fenomeno già registrato nel corso della migrazione post – nuziale ed è stato osservato un aumento anche nelle zone umide della provincia di Napoli). Da segnalare il dato della Moretta: i 91 esemplari sono effettivamente quelli presenti in Provincia di Caserta quel giorno perché sono state visitate in contemporanea tutte le zone umide idonee alla presenza della specie, ci si è tenuti in contatto telefonico per sapere dove erano presenti e pertanto quelle osservate al Lago Patria e alle Mortine sono le uniche presenti quel giorno. Il dato è interessante anche perché il 18 gennaio gli esemplari della specie si erano concentrati in solo due località. Lo hanno fatto per le condizioni meteorologiche? In ogni caso questo dato , ma non solo questo, fa capire quanto sia utile metodologicamente il monitoraggio contemporaneo. A proposito del metodo vale la pena ricordare che l’iniziativa nasce proprio dal dibattito che si teneva al nostro interno negli scorsi anni, quando ci chiedevamo quanto potesse inficiare il dato del conteggio effettuare i censimenti in date diverse, e correre quindi il rischio di avere doppi conteggi per quegli animali che si spostavano a distanza di qualche giorno in un’altra località In questo contesto è risultata stimolante la domanda che si poneva Silvana sull’opportunità o meno di effettuate il monitoraggio in giornate con condizioni meteorologiche particolarmente avverse. E’ uno spunto di riflessione che va accolto e sul quale ragionare. I dati raccolti dimostrerebbero che nel complesso non si è avuta una diminuzione delle osservazioni, anzi. Ciò non vuol, dire, però, che qualche specie possa rendersi meno visibile in particolare condizioni meteorologiche e che, in ogni caso, qualche località può risultare meno esplorabile. Anche per capire se ci fossero differenze nel conteggio e nelle presenze delle specie, d’intesa con Alessio, abbiamo effettuato un conteggio degli acquatici ai Variconi anche il giorno prima in condizioni meteorologiche buone. Temevamo, infatti, che con la pioggia del giorno dopo le anatre si potessero nascondere nel canneto e non farsi vedere. Dal confronto non sembrano emergere differenze sostanziali. Un’altra riflessione che lo stimolo di Silvana porta a fare è che il “cattivo tempo”, in inverno ci sta e può rappresentare una delle variabili: il Lago Matese, ad esempio, era ghiacciato per circa il 60%. Queste sono però solo alcune delle considerazioni che si possono fare, e se ce ne saranno altre che verranno anche a Voi, sarebbe bello confrontarsi su questo tema, considerato anche che siamo gli unici in Italia a sperimentare il metodo della contemporanea e che quindi il dibattito sul metodo ci trova tutti molto appassionati e interessati. Va aggiunto, inoltre, che nel corso dei rilevamenti di gennaio per le zone umide casertane, come ASOIM; abbiamo effettuato, come facciamo ogni anno, anche altre spedizioni di studio e abbiamo registrato altre presenze di specie e di popolazioni in zone che non venivano raggiunte dalla contemporanea e che comunque entreranno nella banca dati dell’Associazione per lo svernamento del 2015. In chiusura vorrei trasmettere a tutti Voi che avete partecipato e a quelli che purtroppo, pur volendo, sono stati impediti da stati influenzali, difficoltà meteorologiche e altri impegni, le sensazioni che ho provato, personalmente alla fine di questa bella esperienza. Alla fine della giornata del 18, raccogliendo le notizie dalle telefonate degli amici delle altre squadre e guardando poi le foto delle varie squadre il giorno dopo su FB, mi rendevo sempre più conto che anche quest’anno avevamo portato a termine un’impresa straordinaria, sia sul piano scientifico che umano. Nonostante una pioggia battente e continua, con a tratti situazioni da nubifragio, un freddo pungente, oltre che piovoso, in montagna, ben 24 persone, senza battere ciglio, si sono messe in auto e si sono presentate agli appuntamenti, in alcuni casi anche molto mattutini. Nessuno si è tirato indietro, tutti hanno portato a termine la missione, in alcuni casi abbiamo anche registrato un bellissimo spirito di squadra, quando ad esempio
Stefano Piciocchi, Danila Mastronardi e Maurizio Fraissinet (a cura di), 2011 – I Rapaci diurni della Campania (Accipitridi, Pandionidi, Falconidi). Monografia n.10 dell’ASOIM Onlus. ASOIM Onlus e Assessorato all’Ecologia e alla Tutela dell’Ambiente
In occasione del suo venticinquesimo compleanno l’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale – ASOIM Onlus – pubblica la sua decima monografia, dedicata ai rapaci diurni della Campania.Il libro di 256 pagine presenta lo stato delle conoscenze derivante da dieci anni di ricerche di campo indirizzate al censimento e al monitoraggio degli uccelli rapaci diurni.Ad un primo progetto di censimento basato sulla tecnica di rilevamento degli atlanti ornitologici, si è andato sostituendo, a partire dal 2005, un nuovo progetto, denominato “night and day” dai soci dell’Associazione, perché vi dedicavano un giorno e una notte del loro tempo. Per sei primavere inoltrate (nel mese di giugno in genere), dal 2005 al 2010, sono stati esplorati in maniera molto approfondita, si potrebbe dire palmo a palmo, alcuni territori della Campania di particolare interesse naturalistico. Nelle visite si sono contati ad uno ad uno tutti i rapaci presenti nel territorio. Altri dati, inoltre, sono stati raccolti nel corso del decennio da altri progetti di ricerca e spedizioni ma anche dai Centri di Recupero della Fauna Selvatica presenti sul territorio regionale.Un decennio di ricerche sul campo che ha coinvolto una quarantina di volontari e che ha prodotto una mole notevole di dati, al punto che è stato possibile raccoglierli in questo libro, fornendo un quadro ampio e completo sullo status di tutte le specie di rapaci diurne note per la Campania.Complessivamente in Campania sono note 29 specie, 12 sono nidificanti, 11 sono migratrici e svernanti, 6 di sola comparsa accidentale. Tra le specie migratrici figura anche il Capovaccaio, un piccolo avvoltoio che ha nidificato in provincia di Salerno fino agli anni ’70.Per ciascuna specie nidificante, migratrice e svernante c’è un’ampia trattazione che ne illustra l’areale, l’ecologia, lo status popolazionistico e conservazionistico a livello planetario ed italiano, per poi soffermarsi sulla situazione campana con una trattazione approfondita e puntuale sulla distribuzione, la consistenza popolazionistica, lo status conservazionistico, gli andamenti popolazionistici e quanto altro sia emerso di interessante nei dieci anni di rilevamento sul campo. Per le specie nidificanti viene pubblicata anche una cartina regionale con l’areale riproduttivo, mentre per alcune specie svernanti vengono pubblicati i dati dei censimenti invernali. Le specie accidentali sono trattate in un capitolo a parte. Il testo riporta anche alcuni elementi per il riconoscimento delle specie in volo.Ma il libro non si esaurisce nell’analisi delle singole specie. Dopo una bella presentazione di Francesco Petretti e dei rappresentanti istituzionali della Regione Campania, nonché un abstract in lingua inglese, vengono ospitati capitoli dedicati alla sistematica, ai metodi di ricerca utilizzati e alla geografia della regione: un capitolo, questo, particolare perché i curatori hanno voluto riprendere un testo pubblicato dal compianto prof. Mario Milone, fondatore dell’ASOIM, nella prima monografia dell’Associazione, volendo in tal modo ricordare, in occasione del traguardo delle dieci monografie, l’illustre zoologo scomparso.C’è una terza parte, infine, dedicata ai rapporti tra i rapaci e l’uomo in cui compaiono capitoli dedicati ai Centri di Recupero della Fauna Selvatica che, con varie vicissitudini e diverse alternanze, da decenni, grazie all’abnegazione di volontari, operano per recuperare e reimmettere in natura animali feriti, sulle principali forme di disturbo umano che incidono non poco sulla sopravvivenza di tali specie nella regione e alcuni capitoli scritti da veterinari della ASL Napoli 1 e della Facoltà di Veterinaria, Dipartimento di Patologia e Sanità Animale, dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, sulle condizioni necessarie per operare in un Centro di Recupero della Fauna Selvatica, su di un caso clinico relativo ad un intervento chirurgico su di un Poiana, sugli studi epidemiologici che vengono condotti su tali animali.Come di consuetudine per le monografie ASOIM il libro si conclude con un’ampia bibliografia specialistica ed è estremamente curato dal punto di vista grafico, sia per la linea editoriale sempre impeccabile e gradevole, sia per l’elevato numero di fantastiche e spettacolari fotografie che ritraggono ambienti e uccelli.In chiusura una considerazione sulla produzione editoriale dell’ASOIM Onlus. Dieci monografie ornitologiche in 25 anni, 3 negli ultimi tre anni, sono una realtà culturale di grande rilevanza che merita attenzione. In primo luogo quasi tutte le monografie rappresentano il risultato finale di anni di ricerche sul campo (fa eccezione solo la quinta che ospita gli atti di un convegno), a dimostrazione di un’attività di ricerca scientifica intensissima, in secondo luogo va rimarcato il sostegno di enti pubblici e privati che in questi anni hanno dato fiducia, ben ripagata, in questa realtà scientifica, peraltro costituita da volontari, che ormai rappresenta una delle tante eccellenze culturali della Campania. Per avere una copia inviare una donazione di 15 euro (che comprende anche le spese di spedizione) al conto corrente postale ccp n. 77237360 intestato a “Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale”. L’ASOIM Onlus utilizza questi fondi per i propri fini istituzionali di ricerca scientifica e conservazione della natura.
La dieta del Falco pellegrino a Napoli in periodo riproduttivo
Viene allegato il pdf del lavoro: Fraissinet M. e De Rosa D., 2010. Sulla dieta in periodo riproduttivo del Falco pellegrino in ambito urbano. Picus, 36: 97 – 103
